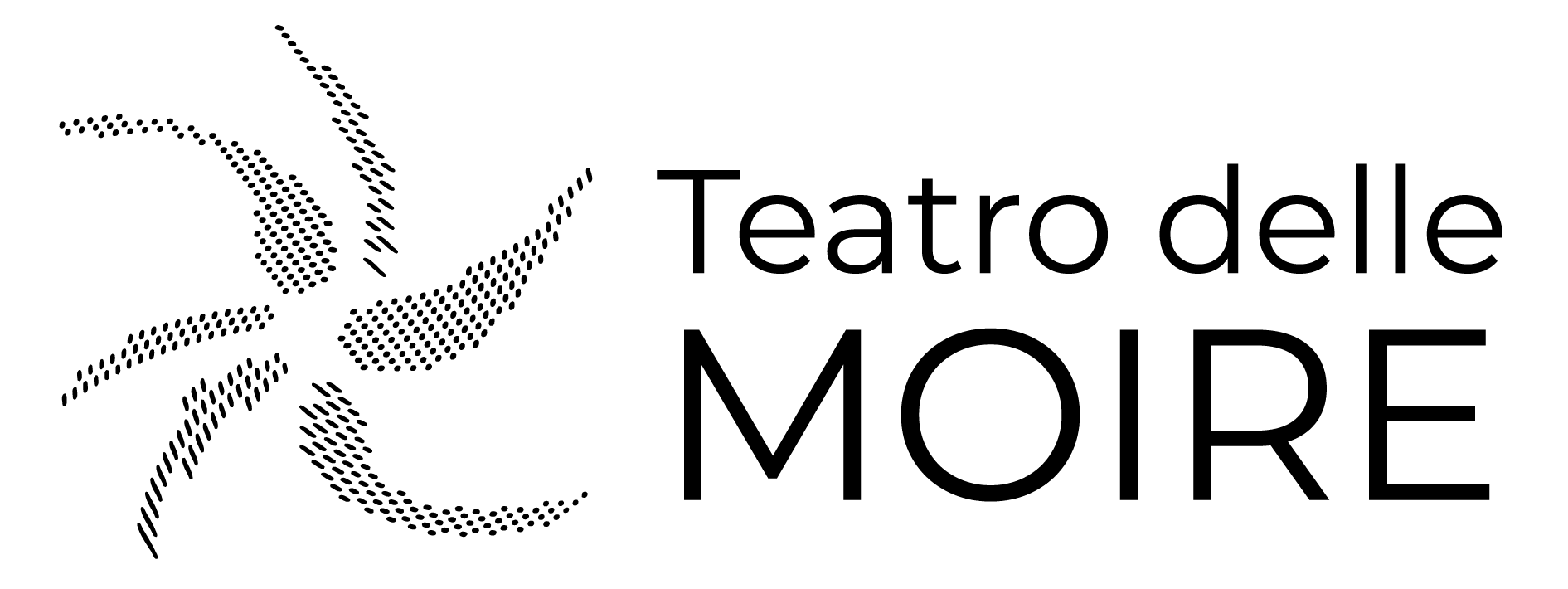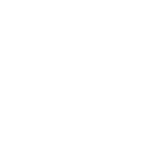Elvis’ Stardust è una breve, malinconica rapsodia di piccoli gesti, di sguardi nascosti, di ritmi lontani. È una voce amata che riaffiora amara, impastata dal tempo in cui è stata in silenzio. È un atto d’amore incarnato, un respirare di stella di cui non resta che polvere nel rapido della sua distruzione.
Un corpo si appropria di un altro e ne rivela sensi nascosti, le ambiguità, le derive ed eventuali sviluppi possibili mai realizzati. Elvis è il performer, l’uno nell’altro, carne nella carne, in un dolce e dolente abbraccio. E sorride, sorridono. Di se stessi, del mondo, della vita. In scena una figura anacronistica, buffa, fuori contesto. Come Ginger e Fred nell’omonimo film di Fellini è grottesca e per questo ancora più commovente. Tutt’attorno il mondo è cambiato, e il gigante di un bianco sfavillante sembra il riverbero di un’eleganza perduta.
Un’apparizione o un folle. Un sosia o un interprete. Oppure Elvis è ancora vivo, e si mostra qui. Come per tutte le star che hanno conosciuto la grandezza del mito, non si è disposti a lasciarlo andare via. Elvis si muove piano, con il peso di un vissuto greve. Attraverso il suo incedere lento sembra volersi riprendere il tempo che gli è sfuggito di mano e che per lui è scorso troppo in fretta.